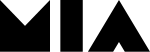Se proprio volete saperlo, confesso. Nell’ultimo anno e mezzo non sono praticamente mai uscito perché sono rimasto in casa a vedere, almeno per me, un sacco di tivù: circa cinque ore a sera. E di questo tempo, neppure un secondo – a parte forse la seconda stagione di Mr. Robot – mi è parso sprecato. In Mad Men e in Transparent ci sono scene che per bellezza e perfezione, intensità e naturalezza, non hanno nulla da invidiare al cinema; e l’episodio di Breaking Bad in cui l’ex insegnante di chimica Walter White seppellisce il denaro accumulato con lo spaccio di metanfetamina – trasformando il bottino in rifiuti o liquami – è tra i più illuminanti prodotti dell’arte. Tolti i notiziari, lo sport e i documentari sui Beatles, era dagli anni Ottanta che non guardavo più la televisione; e anche da giovane non ho mai preso in considerazione l’idea di scrivere per la tivù. Il mezzo era troppo compromesso e il livello complessivo, a parte qualche eccezione, era molto scarso. Quanto al cinema, molti dei registi con cui gli autori collaboravano volevano essere considerati artisti e non narratori, vanità che ha rovinato non pochi registi e lasciato gli autori spiazzati; uno sceneggiatore, al massimo, poteva aspirare al ruolo di spalla fastidiosa che propone a gran voce, un passo indietro, idee per lo più inascoltate. L’unico saggio che un bravo autore drammatico poteva dare di sé era la capacità di scrivere per il teatro, o così pareva. Ma questo accadeva prima: prima della mia scoperta che la televisione, lungi dall’alienare spettatori e autori, era diventata l’integratore sociale per eccellenza. La guardavano tutti; potevo parlarne con mia madre, con i miei figli adolescenti e con i loro compagni di scuola. Andavo a trovare amici all’estero e in ogni paese scoprivo che tutti, come fosse una passione segreta, avevano le loro serie preferite, ci avevano formulato su pareri assai netti, e non vedevano l’ora di restituirti il cappotto, così potevano riprendere la sesta stagione di The Good Wife. Prima che te ne andassi, però, ti sondavano alla ricerca delle tue preferenze, di altra roba bella che magari rischiavano di perdersi; e questo poteva tranquillamente essere lo scambio di opinioni più appassionato della giornata. Oggi non è difficile immaginare che ci sia gente che guarda le serie tv al solo scopo di avere qualcosa da dire a cena. Quando avevo quindici anni, il benevolo editor di una prestigiosa casa editrice, trovando promettente un romanzo che avevo scritto, veniva a trovarmi ogni domenica per darmi lezioni di scrittura. Era fissato con i personaggi: ricorrendo a un’idea presa da Edward Morgan Forster, predicava l’insegnamento che uno scrittore doveva ambire a creare individui “rotondi” anziché “piatti”. Questo risultato si otteneva mediante l’accumulo di particolari, anche contraddittori, perché le persone sono fatte così; e ben presto questi personaggi si sarebbero visti come in trasparenza, fino allo scheletro, e avrebbero cominciato a muoversi per conto proprio. La serie televisiva, grazie alla sua durata, è il mezzo ideale per esplorare il personaggio sotto pressione. Ultimamente ho visto tutti e ottantasei gli episodi dei Soprano, seguiti da tutto Breaking Bad; poi mi sono fatto Gomorra, e avrei voluto che durasse di più. La lentezza di Mad Men – interessante anche per la sua origine letteraria: non si può fare a meno di cogliervi le ombre di Francis Scott Fitzgerald, John Cheever, Richard Yates e John Updike – mi ha irritato e disorientato finché non sono entrato nel ritmo. I personaggi vengono mostrati a letto, in cucina e al lavoro; si riesce a comprendere come la politica e le barriere di genere li abbiano plasmati e anche, misteriosamente, di quanta poca libertà godano. La lunghezza favorisce la complessità. La vista di Tony Soprano che entra ed esce dal bagno con lo stomaco sottosopra, o accompagna l’amatissima figlia all’università prima di uccidere un conoscente a mani nude, è una cosa per cui nel Padrino non ci sarebbe stato lo spazio. Ho afferrato fino a che punto fosse progredita la televisione, e il fatto che aveva sostituito il pop come maggior forma espressiva, quando ho notato che gli autori migliori – da David Chase a Matthew Weiner – le riconoscevano lo status di evento. Da tempo avevano rinunciato all’idea di far vedere che il crimine non paga; e avevano anche buttato dalla finestra l’idea che gli spettatori amino i protagonisti simpatici, rendendosi invece conto che adorano assistere a inganni, falsificazioni e malvagità: vedere gente che fa quel che vorrebbero fare loro, se solo fossero ugualmente dotati di palle, avidità o idiozia. (Ricorderete che Alfred Hitchcock disse: “Più forte il cattivo, più forte il film”). E la nuova televisione ci ha aggiunto un altro ingrediente fortissimo: ha fatto piazza pulita del finale lieto ed edificante. Le serie lunghe sono perfette per osservare da vicino la spietatezze del capitalismo perché hanno tutte a che fare con l’accumulo di denaro, il quale è ormai arrivato a giustificare qualunque malefatta; l’unica concessione alla virtù è l’idea che il denaro serva a procurare sicurezza alla propria famiglia. (Delle famiglie altrui chi se ne importa). Questo grado zero del nichilismo è centrale, per esempio, allo splendido orrore sadomasochistico di Gomorra. La qualità dell’immaginazione, in qualunque società, si trova in correlazione diretta con l’occasione, con lo spazio disponibile e con la fede nella possibilità di sognare, del rischio e dell’esperimento; benché le opere di cui ho parlato siano spesso incentrate sul terribile mistero dell’umana distruttività – oltre che sulla sostituzione dei valori umani con quelli materialistici – la loro esistenza rende onore alla firma autoriale. Inoltre, cosa non meno importante, le serie televisive costituiscono un omaggio all’erotismo della collaborazione, un riconoscimento di ciò che si riesce a creare quando più persone sbrigliano la fantasia tutte insieme. Si servono di molti registi, produttori e attori, e danno agli sceneggiatori – che si formano a decine nei corsi di scrittura creativa – l’opportunità di guadagnarsi la pagnotta con una forma espressiva popolare. L’arte più bella, da Hitchcock ai Beatles, da Pablo Picasso a Miles Davis, mescola sempre la sperimentazione con la popolarità, conduce il suo pubblico dal familiare al nuovo, esplora il non-ancoradetto. E ora mi dispiace, devo andare. Mi sono svegliato pensando con preoccupazione a Don Draper, e non vedo l’ora di tornare in ufficio con lui.
(Hanif Kureishi per Robinson di Repubblica)